
Se il valzer non fosse stato un ballo cosi’ famoso ed importante quale invece e’ diventato,
forse non si sarebbe verificato tanto accanimento a rivendicarne la matrice nazionale da
parte di studiosi francesi e tedeschi.
LE ORIGINI
Sulle origini del valzer sono state scritte montagne di libri e sono state tentate non poche
manipolazioni di dati e documenti. Dato il prestigio del ballo in questione, molti storici
europei hanno anteposto l’interesse nazionalistico a quello della ricerca della pura verita’,
gia’ di per se’ complicata per via della incertezza e della pluralita’ dei riferimenti. Anzi,
proprio il contesto obiettivamente nebuloso ha favorito la proliferazione di ‘studi’
tendenziosi e vari tentativi di depistaggio letterario. Il problema centrale e’ stabilire da quali
balli il valzer derivi: in particolare si tratta di capire se esiste ed e’ dimostrabile un rapporto
tra esso e la volta.
La Volta e’ il piu’ significativo fra i balli di ritmo ternario che sicuramente risalgono ad
epoche precedenti rispetto alla nascita del valzer e che del valzer anticipano le
caratteristiche fondamentali.
Volter vuol dire girare. La Volta e’ una danza antica: consisteva in una serie di giri a destra
e a sinistra. Ai giri si alternavano i salti dei cavalieri e delle dame con una tecnica
particolare articolata in due fasi: i cavalieri, prima eseguivano dei salti molto accentuati e
dopo sollevavano la dama per consentire alla stessa una specie di volo. Gli studiosi
francesi che sostengono la derivazione del Valzer dalla Volta fanno sostanzialmente il
seguente ragionamento: Fino all’anno 1100, tutte le danze di coppia erano eseguite dai
ballerini in posizione affiancata. La VOLTA introduce la posizione di coppia chiusa:
cavaliere e dama, uno di fronte all’altra. Poiche’ coppia chiusa + giravolte sono gli elementi
fondamentali del WALZER, e’ normale mettere in relazione tale ballo con la Volta.
Rémi Hess riconosce che “non esistono prove tangibili in grado di dimostrare l’esistenza di
un legame diretto o di un rapporto di discendenza fra volta e valzer”. Per lui, comunque, la
volta e’ “la prima danza di coppia chiusa, a tre tempi, basata su un movimento di rotazione
della coppia su se stessa (a destra e a sinistra). Inoltre, rispetto alla dinamica del gruppo,
la volta determina un movimento di rivoluzione delle diverse coppie, nello spazio della
danza. Grazie a tutti questi elementi, tale ballo preannuncia indubbiamente il valzer”.
Gli studiosi tedeschi affermano variamente che il Valzer possa derivare:
• dalla Deutscher tanz (Allemanda ternaria popolaresca) sviluppatasi nella Germania
meridionale;
• dal Dreher (Baviera);
• dal Landler (Austria).
E’ stata, comunque, sempre abbastanza diffusa la tentazione di associare il valzer alla
volta, date le somiglianze fra i due balli. Proprio per questo motivo la polemica e il
contenzioso si sono spostati, nel passato, sulle origini della volta stessa, e precisamente
se tali origini siano italiane, provenzali, tedesche o austriache. Dopo decenni di
contrapposizioni, la tendenza attuale e’ quella di considerare la volta un ballo provenzale.
Oggi questa tesi e’ accolta quasi unanimemente; ma fino a quando e’ stata solo una
ipotesi, le scuole di pensiero sulla nascita del valzer si sono divise lungo due indirizzi:
il valzer non deriva dalla volta,
il valzer deriva dalla volta.
Non sono mancati, infine, studiosi tedeschi che, pur prendendo in considerazione la
seconda ipotesi, hanno asserito che anche la volta e’ nata in Germania. Un esempio per
tutti di tale impostazione e’ dato da Fritz Klingenbeck,, il quale ritiene che la volta derivi
direttamente dall’allemanda e che il termine allemanda sia stato coniato dai francesi per
denominare la volta in modo da esplicitarne la provenienza tedesca. Questo ballo sarebbe
37
stato portato in Francia dai soldati (francesi) che erano stati in Alsazia durante la guerra
dei Sette Anni. (L’Alsazia e’ la regione nord_orientale della Francia che ha per capoluogo
Strasburgo. Fu conquistata dai francesi nel 1675. Con la pace di Nimega, nel 1678, essa
fu definitivamente annessa alla Francia). I francesi, poi, lo avrebbero rielaborato: da danza
lenta in ritmo binario, a danza vivace in ritmo ternario. La conclusione di Klingenbeck sulle
origini del valzer e’ la seguente:
Il valzer e’ nato in Germania come risultato di due processi paralleli: nelle comunita’
urbane e’ esso derivato dall’allemanda; nelle comunita’ rurali e nella regione dell’Austria e’
derivato dal landler. (Il landler e’ nato come danza di coppia chiusa a tre tempi).
Molto provocatoriamente, Rémi Hess, introduce il problema delle origini di questa danza
con una affermazione di Castil Blaze, “Il valzer che abbiamo ripreso dai tedeschi nel 1795
era un ballo francese da quattrocento anni”.
MOURGUES MARCELLE, sostiene che “lo studio del passo della volta presenta una perfetta
analogia con il passo del valzer e dell’allemanda”. La differenza tra allemanda e volta e’ la
seguente: mentre l’allemanda e’ una “mera danza collettiva con moulinet, dove il ballo di
coppia rimane aperto, e’ evidente che la volta e’ stata la prima a far si’ che la coppia si
abbracciasse nell’incantevole dondolio del ritmo a tre tempi, nell’ebbrezza di un turbinio
tipico del valzer”. Quindi, il valzer, in quanto derivante direttamente dalla volta, e’ (sarebbe)
francese.
Il famoso storico della danza CURT SACHS, che per decine e decine di balli ha ricostruito al
millimetro nascita, sviluppo, percorsi, interazioni, ecc., proprio sul valzer ci da’ un
contributo solo parziale: sia nel non fissare o non negare, con la sicurezza che gli e’
propria abitualmente, la sua derivazione dalla volta, sia nel lasciare un alone di incertezza
sulle origini della volta stessa. Questo ci fa capire che il problema e’ veramente serio e di
non facile soluzione. Mentre egli afferma che la volta ha come patria la Provenza e “fu
introdotta per la prima volta alla corte di Parigi nel 1556 dal conte Sault”, precisa che cio’ e’
vero nella misura in cui “Carloix, segretario di Vieilleville, ci da’ informazioni esatte”. Cio’
vuol dire che le origini provenzali della volta, ben lungi dall’essere state dimostrate
scientificamente, poggiano unicamente sulle dichiarazioni del sig. Carloix. Non a caso,
subito dopo, Curt Sachs, che e’ abituato a far quadrare i conti, ossia le ipotesi con i fatti,
riferisce due stranezze (tali sono per lui) che gli studiosi non sono riusciti a spiegare:
“Ancora piu’ singolare e’ che gia’ prima del 1600 la volta costituiva in Inghilterra una
parte stabile delle lezioni di danza”.
“Ma ancora piu’ strana e’ la sua prima comparsa in Germania… Gia’ nel 1538 un
incisore della Vestfalia, Heinrich Aldegrever, ritrae in una serie di soggetti di danze
nuziali proprio questa danza, almeno per il particolare dell’uomo che afferra la dama
per il busto”.
Le perplessita’ di Curt Sachs non si fermano qua. “Continuamente gli scrittori francesi
rivendicano alla Francia l’origine del valzer poiche’ si dice che esso sia nato dalla volta.
Senonche’, il motivo coreutico di sollevare in alto la dama si puo’ riscontrare nella
Germania di molti secoli prima”. E ancora: “L’afferrare la dama per il busto che non fa
parte ne’ del valzer ne’ del Landler, era comune in Vestfalia decine di anni prima che la
volta prendesse la via della Provenza verso Parigi e nessuno potrebbe attribuire alla
Vestfalia una particolare inclinazione per i costumi della Provenza”. L’Autore dichiara di
non volere “dar fiato alle trombe tedesche” e conclude che “in realta’ la radice di tutte le
danze con movimenti circolari affonda nell’oscurita’ dei riti di vegetazione del periodo
neolitico”. In ogni caso, la volta “deve essere scomparsa subito dopo” il 1636.
Rémi Hess contesta Curt Sachs, accusandolo di spirito antifrancese e mettendo in
relazione la data di pubblicazione e di diffusione della sua opera (1933) col contesto
politico tedesco del momento, evidentemente contrario all’idea di un valzer collegato alla
tradizione latina. Rémi Hess critica anche FRITZ KLINGENBECK che porta avanti un discorso
tutt’altro che scientifico. Il concetto contestato e’ il seguente: “Anche se gli scritti sulla
nascita di questo ballo sono in gran parte frutto di mere supposizioni, cio’ non toglie che
38
molte testimonianze avvalorino la tesi secondo cui il valzer, in quanto ballo nazionale
tedesco, e’ nato nel nostro paese e appartiene alla nostra cultura allo stesso modo di un
vecchio canto popolare. Proprio come avviene per i canti popolari, e’ impossibile reperirne
la vera origine, ma questo non ha importanza perche’ il valzer e’ tedesco nella sua intima
essenza”.
ARTHUR H. FRANKS, ricorda i tempi in cui “i francesi proclamavano che il valzer discendeva
dalla volta, mentre i tedeschi asserivano che derivava dalla dreher”. Egli sostiene che si
puo’ considerare praticamente chiusa la “lotta” delle rivendicazioni in quanto “la maggior
parte dei vocabolari francesi contemporanei, ivi compreso il Larousse, fanno riferimento
unicamente alle origini tedesche di questo ballo”.
Secondo Giovanni Calendoli il valzer “trae origine dall’evoluzione del landler. (…)
Naturalmente anche il valzer, quando le conquiste della Rivoluzione francese sono
gradualmente assimilate, puo’ ascendere dal basso livello borghese fino ai piu’ elevati
fastigi della mondanita’ ed essere ammesso addirittura nei grandi balli delle corti
ottocentesche”.
L’estremo tentativo di accreditare un qualche aggancio del valzer alle tradizioni francesi e’
quello di Rémi Hess, in nome di motivazioni di tipo interculturale e internazionale: “Il nostro
obiettivo non e’ quello di dimostrare la paternia’a’ francese del valzer, ma piuttosto di
evidenziare la molteplicita’ degli apporti necessari affinche’ emergesse una nuova
socialita’ di coppia, all’epoca della Rivoluzione del 1789, che pur essendo scoppiata in
Francia fu preparata da fermenti diffusi in tutta Europa. La danza di coppia e’ infatti il
risultato di un movimento europeo della durata di quattro secoli”. Rémi Hess resta
comunque convinto che “le origini tedesche del valzer non sono piu’ convincenti di quelle
provenzali”.
FORTUNA DEL VALZER
Rémi Hess ci ricorda che il termine walzer fu usato nel 1754 nella commedia di Josef Kurz,
e precisamente “nella canzone di Bernardon (su una musica in 3/8)”. Nel 1766 lo stesso
termine comparve nel minuetto di una sonatina di Franz Joseph Haydn, precisamente
nella didascalia “mouvement de valzer”. Giovanni Calendoli riferisce che “nel 1782 C. von
Zangen publica un trattato sulla nuova danza intitolandolo Etwas uber das Walzen”. Si
tratta di tre anteprime: infatti, fino alla fine del Settecento, il termine tedesco walzer non fu
ufficialmente adottato per indicare un ballo codificato. Con tale termine si intendeva
inizialmente definire, quindi, non una danza che gia’ avesse delle precise regole e dei
propri schemi, ma solo un modo particolare, estemporaneo o tendenziale, di ballare.
In tedesco walzen vuol dire rigirarsi (in inglese il termine corrispondente e’ waltz); e quindi
si puo’ presumere che, nei due casi citati, il termine walzer stesse ad indicare una serie di
giravolte eseguite in perfetta armonia con le basi musicali. Molti studiosi sostengono che
per centinaia di anni, in tanti balli popolari le coppie hanno eseguito movimenti di costante
rotazione, mantenendo una posizione ravvicinata. In realta’, in ogni danza con battute di
tre battiti, i giri vengono fuori quasi naturalmente, al di la’ delle codificazioni. Fra le
popolazioni dell’Europa centro-meridionale i balli con ritmo ternario sono esistiti fin
dall’inizio del secondo millennio.
Curt Sachs afferma che “la prima documentazione della parola Walzer” e’ Weller, una
danza in tondo che si eseguiva durante le feste nuziali in Germania, definita ”sfrenata” dal
maestro cantore di Norimberga Kunz Has, nel 1525.
Il valzer fu presentato per la prima volta in palcoscenico nel 1787, all’interno dell’opera Una
cosa rara, di Vincent Martin, al Theater an der Wien. Cio’ dimostra che, a quella data, il
popolo era gia’ ben disposto verso tale ballo. Come danza autonoma comincio’ ad
affermarsi all’inizio del XIX secolo, conquistando sempre piu’ adepti, nonostante i moralisti
ne parlassero come di un ballo pericoloso e per la morale e per la salute. Esso aveva un
39
movimento moderato con accentuazione della prima unita’ di battuta. Solo
successivamente da Andante divento’ Allegro.
La diffusione di questo ballo, rapportata alle ‘politiche’ ostili delle Autorita’, ne fa capire
tutta l’intima forza.
Al 1760 risale un importante documento, rinvenuto in Baviera, che vietava espressamente
le “walzende Tanze”.
Nel 1767 J.M. de Chavanne, parlando a nome dei maestri di danza, condannava il valzer
in quanto non rientrante nella tipologia della buona danza.
Nel 1785 il Walzer fu vietato in Boemia (con specifico provvedimento della corona) per
motivi morali ed igienici.
Curt Sachs riporta la descrizione che ERNST MORITZ ARNDT fa di una scena di valzer: la
coppia balla “cosi’ strettamente allacciata” volteggiando “in un atteggiamento
sconvenientissimo”. A proposito dei danzatori che tengono sollevati i lembi dei vestiti delle
dame, nota che “la mano (del maschio) che tiene il vestito poggia ben ferma sul petto della
donna premendo con lascivia ad ogni piccolo movimento”. Il giudizio sulle donne non e’ da
meno: “Le ragazze poi avevano uno sguardo folle o sembravano prossime al deliquio”
Proprio questi divieti ufficiali stanno a dimostrare il successo che il ballo aveva conseguito
nelle varie regioni europee: esso era entrato a far parte delle abitudini del popolo. Alla
gente piaceva sempre di piu’. A dire il vero cominciava a fare breccia anche nelle menti
piu’ aperte della nuova cultura. Curt Sachs sostiene che agli inizi dell’Ottocento si avverte
una stanchezza generalizzata per le vecchie danze europee ed inglesi. Si sente il bisogno
di balli popolari forti, capaci di esprimere le passioni, le emozioni, i giochi dell’amore. “Cio’
che quest’epoca cercava si poteva trovare nei dreher, nei saltarelli, nei landler o nei valzer
che da tempo indeterminato esistevano nella Germania meridionale pronti a lasciare le
loro valli e i loro villaggi, appena fosse suonata l’ora”.
Il valzer riportava l’estasi, l’ebbrezza, il rapimento. Questa sua natura ne spiega il veloce
successo, “la sua rapida accoglienza da parte della borghesia tedesca”. Perfino la difficile
Inghilterra fini’ per adottarlo (1812).
Il valzer fu nobilitato dai grandi della musica:
Danze Tedesche di Mozart (1789),
12 Walzer di Haydn (1792),
Danze Tedesche di Beethoven (1796),
Landler di Beethoven (1799),
Danze Tedesche di Weber (1801).
Il boom del Valzer si ebbe con la Rivoluzione francese che scoppio’ alla fine del XVIII
secolo e le cui ripercussioni varcarono i confini della Francia per investire quasi l’intera
Europa. La Rivoluzione francese affermo’ i principi della liberta’ e dell’eguaglianza: il ballo,
che era stato vietato per tanto tempo, rappresento’ una delle prime manifestazioni della
nuova filosofia di vita.
Non a caso, le rivolte contadine trasformarono in sale da ballo molte chiese e molti
monasteri. In tutte le feste, spontanee o organizzate, del popolo inneggiante agli ideali
rivoluzionari, il ballo principale era il Valzer. Questo ballo fu amato anche dalla borghesia e
dall’esercito. Si scrive che “le truppe napoleoniche lo fecero conoscere a tutta l’Europa,
travolgendo le resistenze dei moralisti”. Essi ricordano inoltre che il valzer sopravvisse
anche al crollo dell’impero di Napoleone. “La restaurazione dei vecchi regimi non significo’
il ritorno delle danze nobili”. Re e regine ne furono innamorati.
Alcuni studiosi hanno fatto notare che la stessa architettura del Valzer ha un contenuto
sociale egualitario. Marlon Giuri e Simona Griggio sottolineano egregiamente tale aspetto:
“Tecnicamente non presentava alcuna differenza d’esecuzione per uomini e donne,
poiche’ quel che contava non era l’emergere della differenza sessuale ma la fusione
dell’uomo e della donna nella coppia. Entrambi gli esecutori compivano i medesimi passi in
perfetta sincronia: l’uno di fronte all’altra, abbracciati, volteggiavano insieme a destra e a
sinistra, girando attorno alla sala in senso antiorario. La ricerca del baricentro di coppia e’
40
alla base di tale uguaglianza tecnica: l’uomo e la donna nel valzer si fondono in un unico
movimento per poter effettuare la rotazione e acquistare la velocita’ desiderata.” Questo
concetto non deve essere frainteso nel senso che si alterna la funzione di guida. E’ sempre
del cavaliere l’onere del condurre. Non e’ da condividere, pertanto, l’affermazione di
Regazzoni_Rossi_Sfragano quando sostengono che il valzer “e’ stato il primo ballo di
parita’ sessuale, nel senso che nella sua esecuzione dama e cavaliere si alternano alla
conduzione”.
In un altro passaggio fondamentale del loro libro, Marlon Giuri e Simona Griggio ci
ricordano l’importanza del parquet: “L’accentuazione del ritmo del valzer e’ strettamente
connessa all’invenzione del parquet che, permettendo ai ballerini di scivolare meglio sul
terreno, provoco’ la scomparsa dell’elemento saltato che fino ad allora caratterizzava il
valzer.”
Sul piano strutturale la musica del Valzer ebbe una svolta importante grazie a Hummel che
costrui’ una forma piu’ complessa di componimento formato da tre elementi fissi:
Introduzione, Walzer vero e proprio, Coda.
Il Valzer di Hummel era meglio articolato, con i periodi (di 48 battiti) ben collegati fra di
loro.
Forse senza volerlo, Hummel diede inizio alla fase della maturita’ del Valzer che divento’
espressione artistica di alto livello. A partire dalle sue opere si attivarono in parallelo due
percorsi musicali separati:
• il valzer ballabile,
• il valzer come composizione pura.
Nell’ambito del ballabile coesistevano il Lento e l’Allegro. La composizione dell’orchestra
era predeterminata dalla scelta del genere musicale. Per i brani ballabili era sufficiente
un’orchestra ‘leggera’, quella che oggi chiamiamo orchestrina. Il filone del valzer ballabile
si sviluppo’ in modo particolare a Vienna dove ebbe interpreti illustri come i Lanner e gli
Strauss. Furono scritte opere di grande respiro; e quando lo stesso Strauss-padre con la
propria orchestra ando’ a suonare a Parigi e a Londra, fu tale l’entusiasmo suscitato dalla
sua musica che automaticamente scoppio’ anche in queste citta’ la febbre per il nuovo
ballo.
Il periodo di massimo splendore del Valzer come ballo si ebbe con Strauss-figlio. Questi,
da grande e raffinato artista qual’era, si propose (riuscendovi in pieno) di adattare la
musica del Valzer ai valori mondani del suo tempo. Con tale intento si allontano’ sempre di
piu’ dalla dimensione classica di Beethoven o romantica di Weber e Schubert per creare
una sintesi perfetta tra momento musicale e momento coreico. Fin dal 1800 Vienna tributo’
grande successo a questo genere musicale che in realta’ rappresentava la fedele
interpretazione della sua mondanita’. Le varie trasformazioni ed elaborazioni tecniche che
hanno fatto del Valzer il ballo che oggi conosciamo sono nate nella capitale asburgica.
Ricorda Rémi Hess che “ai tempi del Congresso di Vienna, la danza riveste una
grandissima importanza. I nobili europei sono ben decisi a riprendere al popolo tutte le
liberta’ che ha conquistato dal 1789; ma al tempo stesso, ballando il valzer, assaporano il
piacere di trasgredire alle regole della loro classe”. “Il Congresso di Vienna ridisegna i
nuovi confini dell’Europa. Al tempo stesso si trasforma pero’ in un enorme corso di ballo,
della durata di cinque mesi, e rappresenta lo strumento di istituzionalizzazione del valzer in
tutti i paesi europei”.
In tutta la seconda meta’ del XIX secolo il connubio danza-musica trovo’ nel Valzer lo
strumento interpretativo artisticamente piu’ elevato. E il Walzer tenne banco non solo
nell’Europa continentale, ma anche in Inghilterra ed in America.
Con l’avvento dell’Operetta, il Valzer del filone ‘ballabile’ conobbe un ulteriore impiego,
incanalandosi nei circuiti del divertimento e puntando soprattutto su valori melodici piu’ che
artistici. Contemporaneamente, l’altro filone spiccava il volo verso valori ideali fino a
sfociare nella lirica pura, attraverso la musica dotta di Berlioz (Damnation de Faust), Liszt
41
(Mephisto), Gounod (Faust), Cajkovskij (La Bella Addormentata nel bosco), a cui si devono
aggiungere brani indimenticabili di Chopin, Brahms, Schmitt, Ravel, Stravinskij. Ma questa
e’ un’altra storia.
Da quanto detto si capisce perche’ il Valzer si chiama Viennese. Si deve comunque
riconoscere alla Francia il merito di aver dato un contributo fondamentale alla affermazione
di tale ballo e di averlo amato fino in fondo. E’ sintomatica la vicenda relativa al capolavoro
di Johann Strauss An der schonen blauen Donau (Il bel Danubio blu), il piu’ affascinante e
il piu’ famoso dei 170 valzer da lui scritti:
Quando nel 1867 usci’ tale opera, nel mondo viennese del ballo l’accoglienza fu tiepida, in
quanto si trattava di un valzer da concerto, difficile da ballare come tutte le solenni melodie
caratterizzate da pause numerose e lunghe introduzioni.
Nello stesso anno, alla Esposizione Universale di Parigi, questo pezzo riscosse un
successo inimmaginabile: fu presentato, accolto e promosso come il valzer piu’ bello di
tutti i tempi. Da quel momento divento’ il simbolo stesso del Valzer.
A Boston nel 1872 “fu eseguito con un’orchestra di 1.087 strumenti, un coro di 20.000 voci,
200 direttori d’orchestra e un pubblico di 100.000 persone”.
Attraverso i decenni, il Valzer Viennese ha mantenuto le sue caratteristiche fondamentali
ed e’ riuscito a sopravvivere non solo a due guerre mondiali, ma alle grandi rivoluzioni che
nel corso del XX secolo si sono verificate nel mondo delle danze. Il maestro Alex Moore lo
definiva ai suoi tempi “uno dei balli piu’ attraenti”, presente in tutte le gare anche quando
queste non erano regolamentate in maniera uniforme. La “musica ispirata” rendeva questo
ballo “gradevole da ammirare”.
Nel corso degli anni, a fronte del successo sempre crescente del Valzer, diversi furono, nei
vari paesi, i tentativi di contaminazione o di imitazione di tale ballo:
• Valzer scozzese (GERMANIA): un misto di valzer a due passi e giri tipici del
viennese.
• Boston (USA): valzer moderato, caratterizzato da giri e da passi avanti e dietro.
• Valzer musette (PARIGI): valzer a contenuto sociale. Con accompagnamento di
fisarmonica, si cantavano la tragedie umane delle metropoli di inizio secolo (1900).
• Waltzer a due tempi (Russia): consta di due passi. Il primo e’ strisciato e si esegue
sui primi due battiti (lento); l’altro e’ scacciato e si balla sul terzo battito.
• Waltzer saltato: si esegue saltando alternativamente su ciascuno dei piedi. Il
cavaliere parte col sinistro.
• Waltzer Louis XV: si tratta di un mix tra valzer e minuetto.
Oggi il Valzer Viennese e’ una delle cinque Danze Standard ed in Italia e’ presente anche
nel Liscio Unificato come danza tradizionale del nostro paese, assieme a Polka e Mazurka.
In forma brillante lo si ritrova nel liscio romagnolo e piemontese e in tante interpretazioni,
suonato anche piu’ velocemente rispetto alle previste 56-58-60 battute al minuto.
(fonti: www.emmedance.altervista.org)

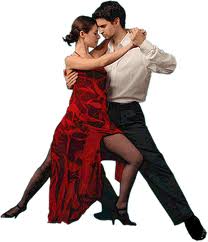



 Giro rovescio
Giro rovescio
 Cavaliere (vedi figura)
Cavaliere (vedi figura)
 Dama (vedi figura)
Dama (vedi figura) Cavaliere (vedi figura)
Cavaliere (vedi figura)