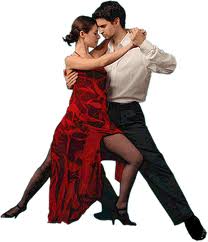27
dicembre
Storia del tango
|
Siccome le ipotesi sulla deriazione del nome tango sono tante, lo stabilire con certezza da dove esso derivi, aiuta ad orientarsi nella costruzione della storia delle origini di questo ballo misterioso. Ecco un elenco delle piu’ plausibili. |
Il Diccionario de la Real Academia Espanola, del 1803, riporta che il termine tango esiste dal 1736 col significato di ossicino. |
|
Il ritmo e’ di derivazione negra. Piu’ precisamente, prende le mosse dalla habanera cubana, a sua volta emanazione di motivi africani portati dagli schiavi in America Latina nel XVIII secolo. Dopo la morte di Carlos Gardel, assieme al mito del personaggio, crebbe l’amore per il tango. Dal 1940 in poi, a parte la pausa bellica, si assistette ad un crescente interesse per il tango, anche dal punto di vista artistico-musicale. In Argentina molte scuole e molte orchestre proposero varianti stilistiche che influivano direttamente sul piano del ritmo. Alcuni musicisti tornarono ad un tango piu’ veloce e piu’ vicino a quello delle origini, riproponendo un tempo di 2/4. |
|
L’ARGENTINA |
|
La svolta artistica nella musica del tango si ebbe nel 1900, quando al posto del flauto fu inserito il bandoneo’n, una piccola fisarmonica a sezione esagonale, con maniglia e tasti a bottone. Secondo Elisabetta Muraca la parola bandoneo’n e’ stata creata “sul modello akkordeon, sommando il suffisso eon al cognome del suo inventore, il tedesco Heinrich Band”. |
|
Il ritmo del tango ha due caratteristiche particolari: e’ fortemente cadenzato ed ha una melodia non uniforme che e’ piu’ spinta e meno spinta, nell’ambito di uno stesso brano: cio’ comporta una accelerazione e una decelerazione dei passi, in armonia con la musica. Le coreografie hanno dovuto tener conto, fin dall’inizio, della particolare struttura ritmica di questo ballo. Cio’ spiega perche’ il tango si e’ subito prestato a tante interpretazioni personali e perche’, anche quando e’ stato codificato, ha dato origine a molte figure di varia lunghezza con caratteri stilistici diversificati. La posizione della coppia e’ nata sotto i migliori auspici: cavaliere e dama erano praticamente abbracciati strettamente, in modo tale che la dama potesse percepire i movimenti anche improvvisati del partner, i bruschi cambi di direzione, e farsi guidare senza problemi. Intuizione ed intesa erano virtu’ fondamentali. Non a caso, la donna del tango era chiamata seguidora: doveva saper seguire il cavaliere con leggerezza, eleganza e perizia. Nei bordelli, le ballerine piu’ ricercate non erano le donne piu’ belle o piu’ sexy; ma quelle che meglio sapevano farsi guidare nel tango. Checche’ se ne dica, la vera sensualita’ di questo ballo consisteva, non tanto negli abbracci e negli intrecci delle gambe, come i benpensanti credevano; ma nella intesa immediata, nella complicita’ totale e maliziosa, intuitiva ed istintiva, che nel silenzio si stabiliva fra i partners: una specie di intimita’ senza parole, una compenetrazione molto piu’ profonda del semplice contatto fisico. Capitava di notare un uomo e una donna, mai vistisi prima, che riuscivano a formare una coppia perfetta di ballerini gia’ alla prima prova, pur nella mutevolezza delle figure e dei tempi. Nelle piu’ spericolate coreografie, trionfavano improvvisatori dalla guida decisa e femmine che apparivano fatali, volitive, aggressive… ed erano docilissime nel ballo. Per dirla con Marlon Giuri e Simona Griggio, “il tango non codificava i modi del corteggiamento, ma un’ambigua e contraddittoria volonta’ di possesso”.
F. Giovannini presenta una distinzione fra programma di TANGO BRASILIANO e programma di TANGO ARGENTINO. L’introduzione di termini francesi significa che e’ gia’ avvenuta una prima europeizzazione del tango:
|
|
Il primo film sul tango arrivo’ in Europa nel 1900. Questo nuovo ballo fu percepito come una delle tante curiosita’ esotiche, con i requisiti giusti per suscitare l’interesse del pubblico. Nel 1908 il tango fu inserito come ballo nelle riviste musicali parigine. Nello stesso anno il piu’ famoso maestro francese, Giraudet, riconobbe il tango come danza. Nel 1910 il direttore dell’Accademia di danza, maestro Battallo, ballo’ personalmente il tango con la star Mistinguett: cio’ equivalse alla legittimazione ufficiale di tale danza che, da quel momento, entro’ in tutte le sale da ballo. Nel 1911 il tango fu presentato alla Esposizione Universale di Parigi, provocando grandi entusiasmi da un lato e critiche e condanne dall’altro. Per molti anni esso ebbe un doppio destino:
Insomma, trovo’ in pari misura convinti detrattori ed entusiasti proseliti. A favore del Tango si schierarono quasi tutti i ballerini e gli studiosi di danze di coppia. Costoro capirono immediatamente che era nato il piu’ affascinante dei balli. Lo stesso pubblico che ruotava attorno agli spettacoli relativi alle danze sembro’ apprezzarne entusiasticamente la portata rivoluzionaria. Il mondo accademico e le gerarchie ecclesiastiche ne furono indignati ed espressero parole di dura condanna. Era difficile far accettare come danza nobile ai rappresentanti del Sistema di allora un ballo inventato nei postriboli, usato come sollazzo da ubriaconi e prostitute. Ne’ si erano mai viste, nemmeno nella tollerante Parigi, coppie di ballerini “esibirsi in posizioni cosi’ sconvenienti ed equivoche“. La stampa (Le Figaro in testa) non perse l’occasione per lanciare un sincero allarme, sostenendo che il Tango era un attentato alla Morale, in quanto consentiva ad un maschio e ad una femmina di fare in pubblico cose che anche nel privato avrebbero fatto arrossire le persone perbene. Per fortuna i Professeurs de Danse furono piu’ realisti e lungimiranti dei giornalisti. Colsero la potenza di questa danza e si misero al lavoro per renderla “compatibile”. La famosa insegnante di ballo Gladys Bettie Crozier, che aveva scritto sul tango un libro importante (The Tango and How to Dance It), nel 1913 aveva modo di descrivere in termini positivi e rassicuranti il tango ballato a Parigi. Lo definiva sciolto ed armonioso, elegante e di belle figure. Poco tempo dopo la presentazione alla Esposizione Universale (1911), e fino allo scoppio della prima guerra mondiale, la moda del tango esplose sia a Parigi che a Londra. Fiorirono dappertutto delle orchestrine attrezzate per suonare il tango, e molti locali (caffe’ e ristoranti) si riciclarono allo scopo di ospitare ballerini di tango. Questi ritrovi si chiamavano tango teas: al centro del salone c’era spazio sufficiente per consentire di ballare; tutt’attorno erano sistemati i tavolini per le consumazioni. Fra una portata e l’altra, mentre l’orchestra suonava ininterrottamente, le coppie si alzavano ed eseguivano un tango. A Londra i the’ dansant nacquero come veri e propri clubs riservati alla media ed alta borghesia. Alcuni di questi clubs, come e’ sempre stata ‘buona’ abitudine degli inglesi, erano anche abbastanza selettivi. In Argentina, patria del tango, questo ballo usciva, poco a poco, dal ghetto e, fin dal 1907, comincio’ ad essere ballato nei salotti e nei teatri. Poi conquisto’ i piani alti della politica, degli affari e della cultura. Avvenne un fenomeno strano: il vero successo esplose dal 1913 in poi, solo dopo che l’Europa e la Francia ne avevano fatto il ballo del momento. A Buenos Aires furono aperti locali lussuosissimi, arredati secondo la moda parigina. I cabaret piu’ famosi portavano nomi francesi: Le Moulin Rouge, Le Royal Pigalle, Chanteclair, Julien, Les Ambassadeurs. In tal modo, l’Argentina adottava ufficialmente il tango come il suo ballo, dopo averlo inventato e snobbato. Esso diventava, nelle grandi citta’ e nei piccoli centri, la piu’ grande attrazione artistica. Per le persone altolocate era un obbligo partecipare alle danze nella forma piu’ solenne. Signore elegantissime e cavalieri in frac e papillon diventarono, frequentando specifiche scuole o servendosi di istruttori privati, ottimi ballerini di tango.
Il successo mondiale del tango porto’ ad una proliferazione di figure e di tecniche. Ogni pista da ballo proponeva un suo tango. Ogni scuola sfornava originali coreografie. Molti studiosi di teoria cominciarono a dire che era arrivata l’ora di una regolamentazione. Gia’ verso il 1914 i famosi insegnanti newyorkesi Vernon e Irene Castle approntarono un manuale di figure e di tecnica. Il discorso della sistematizzazione si interruppe con lo scoppio della guerra. |
|
Il tango appartiene alla disciplina DANZE STANDARD, con i tre programmi Bronzo, Argento e Oro. Il manuale della ANMB propone un programma complessivo di 23 figure. In Italia il tango e’ inoltre presente nella disciplina BALLO DA SALA con un programma autonomo di 19 figure Abbiamo inoltre il TANGO ARGENTINO cjhe le Associazioni ANMB, FIDP, FITD hanno inserito fra le discipline ufficiali. In Italia, attualmente, per gli esami di maestro si fa riferimento al testo di Franco Giombetti e Arianna Storace TECNICA DI TANGO ARGENTINO. Il programma proposto e’ una sintesi delle figure piu’ significative che si vedono in giro ed e’ articolato in tre sezioni (livelli): Bronzo, 10 figure; Argento, 7 figure; Oro (programma libero). Vengono inoltre presentate 6 figure di TANGO VALS e 7 figure di MILONGA, tutte catalogate Argento. |
(fonti: www.emmedance.altervista.org)
This entry was posted on martedì, dicembre 27th, 2011 at 00:28 and is filed under Senza categoria. Follow the comments through the RSS 2.0 feed. Comments are closed, leave a trackback from your site.